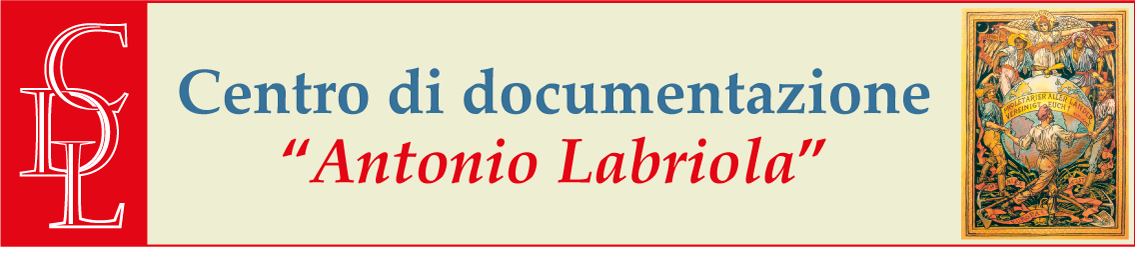Introduzione
Il merito delle memorie di Aldo Garino, raccolte nel testo “Perché raccontassimo”, è di sfuggire ai luoghi comuni più abusati a proposito di memorialistica resistenziale e di offrire una testimonianza efficace in una forma antiretorica e per nulla scontata nei contenuti. Garino narra con ironia, e talvolta vero e proprio umorismo disincantato, di amicizie, amori liceali, e poi fughe, sbandamenti. Anche la prigionia, i cui dettagli potrete ascoltare nella prima delle due letture proposte dalla figlia Laura che qui ringraziamo per la sua disponibilità. Un vero e proprio romanzo di formazione in cui il protagonista, anche per fare i conti con la propria tormentata epoca, approda alla responsabilità, all’impegno e al rischio, senza epica, ma con un intimo e mai ostentato senso del dovere.
- La barbarie della Seconda guerra mondiale
Pur affrontando le vicende di una storia personale, il racconto non perde mai di vista il contesto europeo ed internazionale più ampio, da cui emergeva il fenomeno della Resistenza.
Molte delle polemiche contemporanee sui caratteri e le motivazioni della Resistenza, troppo spesso improntate ad una vuota polemica elettoralistica, ignorano paradossalmente un macroscopico dato di fondo: quel fenomeno deve necessariamente essere collocato nel contesto di uno spaventoso massacro, quale fu la Seconda guerra mondiale. Ogni genere di abominio venne mobilitato in quel conflitto catastrofico, dai campi di concentramento alla bomba atomica, dal genocidio al bombardamento sistematico delle popolazioni civili delle città. Una barbarie, ma moderna e capitalistica, dove la base reale della forza bellica e militare fu la capacità produttiva e la mobilitazione industriale: ed è su questo versante che il fascismo dimostrò tutta la sua impreparazione e la sua approssimazione. Aldo Garino appunta con amara ironia a proposito di quel regime di cartapesta: «Spezzeremo le reni alla Grecia, meglio un giorno da leone che cento da pecora, non burro ma cannoni, otto milioni di baionette, vincere e vinceremo! Velenose imbecillità, idiozia collettiva».
La chiamata alle armi della Repubblica sociale è uno spartiacque di vita che Aldo rifiuta in coerenza con i suoi valori comunisti libertari e con un ancoraggio più che istintivo al movimento operaio e alla sua storia.
- Il legame con il movimento operaio
Non è un caso che nel suo discorso in una Settimo appena liberata - che apprezzerete nella seconda lettura – Garino condanni il tributo di sangue imposto da tutti i conflitti del ’900, non solo promossi dal fascismo, ma anche la patriottica Grande Guerra, e nello stesso tempo ricordi i caduti e le vittime sul lavoro: «Questi sono i frutti del sistema – dichiara nel suo discorso - , questi sono i risultati di certi rapporti sociali, dell’iniquità e perniciosità del potere asservito alle leggi del profitto». Il richiamo ai Martiri di Chicago del 1887, e quindi alla tradizione del Primo Maggio come data simbolo dell’unità dei lavoratori di tutto il mondo, non è quindi episodico e neppure il riferimento ai «caduti del 1922», in particolare quelli della strage fascista di Torino del 18 dicembre, con l’assassinio del segretario della FIOM Piero Ferrero, cui era molto legato Maurizio Garino[1], padre di Aldo e protagonista delle battaglie operaie torinesi del primo dopoguerra. Anche i fascisti, compresi quelli giustiziati, erano magari «spie, traditori assassini, ma comunque sempre e solo ultime rotelline del mostruoso ingranaggio. Disgraziati sgherri, nient’altro. Ben più in là e ben più in su occorre ricercare i veri responsabili».
- La Resistenza prigioniera di Yalta
In Garino si ritrova anche un passo in più rispetto al semplice rimpianto, presente in molta della memorialistica partigiana, circa la “Resistenza tradita”: «Chi non sa che alla conferenza di Yalta, nel febbraio del 1945, Unione Sovietica, Stati Uniti e Inghilterra si sono divisi la futura Europa cosiddetta libera in rispettive zone di influenza?». Già Roberto Battaglia nella sua “Storia della Resistenza Italiana”, pubblicata da Einaudi nel 1953, scriveva di «una diffidenza verso la politica propriamente detta da parte del partigiano comune», ma in queste considerazioni di Garino si avverte una visione più ampia, che arriva a individuare il tema della Resistenza presa in ostaggio dal sistema internazionale dei rapporti tra le potenze. E più ancora sullo sfondo si intravede la denuncia dello stesso stalinismo che di quel sistema internazionale fu uno dei pilastri. Temi che proprio negli ambiti comunisti libertari dei GAAP[2] si ritrovano in maniera compiuta e organica, in particolare nell’elaborazione di Arrigo Cervetto, anch’egli giovanissimo partigiano, che il 15 ottobre 1953 scriveva su “L’Impulso” un articolo dal titolo “La Resistenza prigioniera di Yalta”[3] dove si legge: con la Resistenza si affermava «un nuovo costume, una nuova morale», opposte alla «velenosa educazione ventennale. Nasceva finalmente un eroismo nuovo, antiborghese, antitradizionale: l’”eroismo di massa”, con le sue grandi figure e con le migliaia di anonimi. Nasceva finalmente, quell’impulso sovietista che gli anarchici e i comunisti nel movimento dei Consigli di fabbrica del dopoguerra rosso tanto avevano cercato nelle tradizioni storiche dei lavoratori».
- Le «cause profonde di tante sciagure»
Con il testo di Aldo Garino non abbiamo quindi solo una testimonianza individuale, pure pregnante e di grande interesse, ma uno stimolo a considerare le profonde motivazioni che spinsero una intera leva di combattenti di tutta Europa a lottare per un mondo senza frontiere e senza sfruttamento: «Perché la storia – leggiamo in “Perché raccontassimo” – non abbia a ripetersi bisogna dunque rimuovere le cause profonde di tante sciagure». Una conclusione che oggi non possiamo non condividere di fronte alle «sciagure» contemporanee, di fronte alle decine di milioni di rifugiati in fuga dalle decine di guerre in corso, di fronte allo sdoganamento del razzismo nel discorso pubblico, di fronte alla clamorosa imprevidenza sociale con cui si affrontano le moderne pandemie.
Scheda del libro Letture di Laura Garino dal libro "Perché raccontassimo"
Abbiamo rivolto alcune
domande a Laura Garino,
figlia di Aldo e curatrice del libro
D. Perché è nato
questo libro?
R. Mio padre è stato medico di base per quarant'anni: quando è andato in pensione nel 1989 ha pensato di mettere per scritto i ricordi riguardanti la sua partecipazione alla lotta partigiana. Non era possibile questo racconto senza una ricostruzione dell'ambiente familiare e politico che ha preceduto la sua decisione di salire in montagna a 19 anni, rischiando il tutto per tutto per l'affrancamento da un regime che aveva portato l'Italia in una situazione da incubo. Il libro diventa un vero e proprio album che con precisione fotografica racconta l'infanzia alla Barriera di Milano, in una modesta casa di ringhiera con un maleodorante pozzo nero nel cortile e l’unico lusso di un terrazzino dove giocare. E l'arrivo in casa di libri messi all'indice dal regime, con autori come Socrate e Spinoza, Kant e Voltaire, Bakunin e Kropotkin, Darwin e Marx, grazie alla passione per la cultura e la lettura del padre. Così come sono formative le frequenti discussioni con parenti e amici, tutti di orientamento antifascista.
Tutto questo perché mio nonno Maurizio, anarchico, in prima linea durante le lotte operaie del primo dopoguerra, era schedato come sovversivo, era regolarmente "fermato" in occasione delle visite dei gerarchi in città ed era scampato per un soffio alla strage del 18 dicembre 1922. Dopo innumerevoli licenziamenti per motivi politici aveva fondato una cooperativa di meccanici modellisti, che quando vennero soppresse le cooperative divenne società per azioni, la SAMMA. E pur ritiratosi dall'attività politica palese per amore della moglie, era sempre rimasto coerente nelle idee e nei fatti.
Tutto questo è raccontato nella prima parte del libro. Un libro nato non per la pubblicazione ma per raccontare a noi figli questo periodo travagliato della sua vita.
Solo alcuni anni dopo la sua morte, avvenuta nel 2004, io ho ripreso in mano il manoscritto e ho deciso di digitalizzarlo, di rendere uniforme la bibliografia, di scansionare le fotografie malamente fotocopiate...
Poi
ho pensato di farlo leggere a delle amiche che avevano conosciuto mio padre, e
da loro ho ricevuto la spinta a cercare il modo di farlo pubblicare. Non dirò
che è stata cosa facile trovare la strada giusta per la pubblicazione. Ma dopo
alcuni tentativi infruttuosi, quando avevo quasi deciso di lasciar perdere, ho
incrociato per caso la strada dell'ISTORETO[4],
nelle persone di Barbara Berruti e
Andrea D'Arrigo. E il libro ha visto la luce!
D. Perché questo titolo e questo sottotitolo?
R. "Perché raccontassimo", così si conclude una lettera che mio padre mi scrisse per il ventennale della Liberazione. In questa lettera, con cui ho voluto aprire il libro, egli racconta la fucilazione di quattro giovani, avvenuta nella primavera del '45 in corso Giulio Cesare, sotto casa sua. Solo uno dei ragazzi aveva potuto lanciare un ultimo disperato grido, un'invocazione alla pietà e alla madre. E mio padre concludeva così la sua lettera: «Ma chi ha gridato? Di chi era la voce che è dentro di me, che sarà sempre dentro di me? Uno solo ha potuto ancora gridare, ma la voce era di tanti, di tanti altri giovani, morti così, innocenti, perché noi udissimo, perché raccontassimo…»
La sua urgenza di raccontare è diventata la mia. Coloro che hanno vissuto questi avvenimenti tremendi sono quasi tutti scomparsi. E allora chi racconterà, perché non si perda memoria?
Per quanto riguarda il sottotitolo: mio padre racconta le sue vicende partigiane in modo assolutamente antieroico, con il tono discorsivo e spesso ironico di un testo destinato in origine ad avere come unici lettori noi figli.
In realtà proprio questo stile narrativo, un racconto verbale messo per scritto, contribuisce a dare al libro un carattere unico e inconfondibile. Non solo descrizioni di combattimenti e marce nella neve, ma anche la lotta senza quartiere contro cimici e pidocchi, non solo la fuga drammatica dai rastrellamenti ma anche il freddo e la fame, e l'angoscia di dover abbattere un animale per poter mangiare e sopravvivere. E ancora l'allestimento di uno spettacolo per valligiani e compagni di lotta per combattere la paura della morte e di ciò che verrà. E la descrizione della detenzione alle carceri Nuove, affrontate con serenità perché vissute con il padre.
D. Perché leggerlo ora, e chi lo dovrebbe
leggere?
R. I temi politici più generali, e in particolare le riflessioni di Aldo sul futuro dell’Italia liberata che fanno la loro comparsa nella seconda parte del racconto, nel confronto tra vecchi militanti antifascisti e suo padre, e ancora di più alla fine del libro, nel confronto con la popolazione di Settimo appena liberata, fanno riflettere sulla loro attualità. Sono avvenimenti di quasi ottanta anni fa, narrati a freddo quaranta anni dopo... ma potrebbero essere stati scritti ieri! L'analisi di ciò che si desiderava avvenisse e di cosa sia in realtà accaduto è lucida, a tratti cinica. Non c'è ottimismo, non c'è speranza di un mondo più giusto. Dovrebbero leggerlo quelli che hanno vissuto, anche indirettamente e attraverso racconti, quei tragici giorni. Ma anche quelli che sono cresciuti nell'Italia del dopoguerra e degli anni Sessanta, pieni di promesse ben poco mantenute. E i ragazzi di oggi, magari chiedendosi cosa avrebbero fatto loro nelle stesse situazioni. Proprio grazie alla quotidianità dei fatti narrati ci si può agevolmente calare nei panni del narratore, chiedersi se si sarebbe stati tanto inclini non tanto a perdonare né a dimenticare, ma a voltare pagina e guardare avanti.
Infatti quando mio padre con l'amico Felice ferma quattro sospetti fascisti riflette: «Penso ai tre corpi straziati nel cortile della scuola di Settimo. E al carretto su cui son stati buttati e portati via, un carretto usato di solito per il letame di stalla. Penso a quel tizio della X MAS che nei boschi di Mondrone mi ha lasciato perdere e se ne è andato. Non mi piace avere debiti. Con Felice non ho scambiato parola, neanche uno sguardo d’intesa, ma mi sa che pensiamo le stesse cose e siamo arrivati alle medesime conclusioni. I quattro signorini ci guardano, col fiato sospeso. È uno sguardo che conosco. È il mio sotto i pini di Mondrone... Largo – diciamo alla gente – li lasciamo andare. La folla si scosta e apre un varco. La macchina può proseguire. Lentamente sguscia dalla calca e se ne va. Addio, repubblichini, ho saldato il mio debito. Spero, per l’avvenire, di non avere più niente a che fare con voi e che non ci facciate più girare i coglioni».
Si volta pagina. Si ricomincia a vivere, a far vivere gli altri come medico di base per 40 anni.
[1] Maurizio Garino, protagonIsta negli anni ’10 del ‘900 di tenaci campagne antimilitariste, sostenne l’opposizione rivoluzionaria alla Prima guerra mondiale. Nel 1919 divenne uno dei massimi dirigenti della FIOM torinese e allacciò stretti rapporti con il gruppo dell’”Ordine Nuovo” di Gramsci. Nel dopoguerra è stato dirigente dell’Associazione Nazionale Perseguitati Politici Antifascisti (ANPPIA) di Torino. Cfr Franco Andreucci, Tommaso Detti, ll movimento operaio italiano – Dizionario biografico, Editori Riuniti, 1975, volume 2, pag. 439; Franco Bertolucci (a cura di), Gruppi Anarchici di Azione proletaria – Le idee, i militanti, l’organizzazione, Edizioni Pantarei e Biblioteca Franco Serantini: volume 1, pag. 762.
[2] Gruppi Anarchici di Azione Proletaria.
[3] “Opere”, volume 2, pag. 405.
[4] Istituto piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”.
Speciale 25 Aprile 2020: Introduzione Spagna clandestina
La Resistenza tedesca al nazismo Nel Ghetto di Varsavia Letture