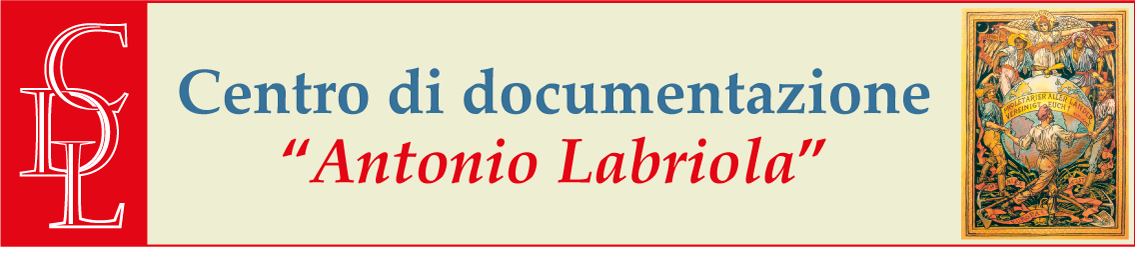LA RESISTENZA OPERAIA AL NAZISMO: 1933-1945[1]
La resistenza degli operai tedeschi al nazismo fu un fenomeno ampio e significativo che prese le mosse fin dall’avvento del nazismo e proseguì in varie forme, ma con ostinata continuità fino al termine della Seconda guerra mondiale.
Immediatamente dopo la nomina di Hitler a cancelliere il 30 gennaio del 1933 si sviluppò una massiccia agitazione ad Amburgo, Berlino, Dresda Duisburg, Düsseldorf, Elmshorn, Essen, Freital, Lubecca ed in altri centri della Germania, con dimostrazioni di massa, cortei e duri scontri con la polizia e le milizie naziste. Scrive Willy Brandt nelle sue memorie, con una evidente nota di rammarico e protesta verso l’atteggiamento della socialdemocrazia :
Essere pronti e non venir chiamati: ci può essere una delusione più grande? La stragrande maggioranza dei lavoratori di Lubecca era pronta a scioperare e a lottare per salvare, insieme all’onore, la pur non amata repubblica (di Weimar, ndr). E perché Lubecca avrebbe dovuto rappresentare un caso isolato? La sera del 31 gennaio 1933 Julius Leber[2] fu aggredito da un manipolo di SA. Uno dei nazisti in uniforme rimase ucciso. Quando la notizia dell’arresto di Leber si diffuse ci fu di nuovo fermento tra i lavoratori […] Cercai, insieme ad un paio di amici, di mettere in moto uno sciopero generale di protesta: andammo dal capo della Lega dei sindacati. Questi, di fronte alla nostra richiesta, perse il controllo dei nervi: “Togliete questa roba dalla mia scrivania. […] Aspettiamo direttive e non ci facciamo provocare”. Tuttavia, il 3 febbraio ci fu in città un’astensione dal lavoro […]. E il 19 febbraio, con un freddo atroce, Lubecca conobbe il più grande corteo dal 1918[3].
Operai contro il nazismo
A pochi mesi dalla presa del potere, in nome della sua politica “sociale”, il nazismo riconobbe il Primo Maggio come giornata festiva ufficiale. Nei giorni immediatamente successivi però le SS e le SA occuparono le sedi dei sindacati e dei giornali di sinistra e si scatenò una massiccia ondata di arresti. Molti fonti storiografiche hanno evidenziato la scarsa resistenza incontrata nella circostanza dalle squadracce naziste, quasi scambiandola per una sorta di resa concordata. Tuttavia, uno studio più accurato degli eventi ha portato a conclusioni notevolmente diverse. Ad esempio, nel solo quartiere di Koepenick a Berlino nella settimana a cavallo tra il mese di aprile e di maggio 1933 vennero uccisi 91 esponenti comunisti e socialdemocratici, segno inequivocabile di un attacco che si dimostrò brutale e particolarmente violento, non certo di un ordinato e pacifico passaggio di consegne.
Negli anni successivi la resistenza operaia, nonostante la feroce repressione e la presa di massa delle campagne propagandistiche del regime, proseguì in termini qualitativi e quantitativi perfino sorprendenti. Nel 1934 e nel 1935 le elezioni dei fiduciari aziendali furono segnate da una vasta astensione; in diversi casi vennero addirittura rifiutati i candidati del regime e imposti esponenti dell’opposizione socialdemocratica e comunista. Fino a che, a partire dal 1938, il governo di Hitler non osò più effettuare elezioni direttamente nelle fabbriche per il timore di una pubblica sconfessione. Nel 1936, l’anno delle Olimpiadi, punta del consenso del regime, secondo i calcoli della Gestapo, vennero diffusi nelle fabbriche tedesche 1.643.000 volantini dell’opposizione: un gesto che, va ricordato, era considerato passibile di alto tradimento e punito con il carcere o con la morte[4].
Tra l’inizio del 1936 e l’estate del 1937 si registrarono ufficialmente 200 scioperi: pesavano i forsennati ritmi produttivi e l’aumento dell’orario di lavoro di cui le aziende potevano beneficiare grazie al decreto del 26 luglio 1934. Episodi sostanzialmente isolati, distribuiti nei numerosi cantieri stradali aperti dallo Stato per costruire in tempi accelerati una moderna rete di trasporti, oppure in fabbriche medie e piccole dove il collegamento delle lotte con altri stabilimenti risultava assai difficile. Ma non mancarono agitazioni in grandi stabilimenti come alle carrozzerie della Opel di Rüsselsheim il 25 giugno 1936, alla Auto Union dove lo sciopero riguardò almeno 600 operai o, ancora, ai cantieri navali di Brema. Per contrastare il ciclo di scioperi del biennio 1936-37 furono arrestati più di 11.000 lavoratori, un’entità che richiama, più in generale, la dimensione non trascurabile dell’opposizione tedesca al nazismo. Il saggista francese Jacques Nobecourt[5], in uno dei primi studi in materia pubblicato il 21 luglio 1964 su “Le Monde” in occasione del ventennale dell’attentato a Hitler, valuta in un milione i tedeschi imprigionati nei campi di concentramento dal 1933 al 1939, cioè prima dell’inizio della guerra. Secondo lo storico tedesco Peter Hoffman alla metà degli anni Trenta in tutta la Germania agivano circa un migliaio di gruppi organizzati, composti anche solo da qualche unità, che si richiamavano in vari modi al socialismo o al comunismo. Tra questi va menzionata l’attività dell’operaio Robert Uhrig che nel 1938 cercò di ricucire i contatti tra queste piccole entità resistenziali: con la sua opera coraggiosa riuscì a costruire un’organizzazione con una capillare presenza di oppositori nelle fabbriche di Berlino, in particolare alla Osram. Il patto Ribentropp-Molotov, approvato dalla direzione del KPD a Mosca, provocò però disorientamento tra le fila dell’opposizione operaia, con conseguente sbandamento dell’organizzazione Uhrig. Nella primavera del 1942 la Gestapo catturò 170 esponenti del gruppo, tra cui lo stesso Uhrig che venne giustiziato nel 1944. Tra gli aderenti al gruppo vi fu anche il popolare atleta Werner Seelenbinder, campione nazionale di lotta greco romana, arrestato nel febbraio del 1942, anch’egli giustiziato nel 1944.
L’organizzazione di Uhrig sopravvisse attraverso una carsica presenza di piccole cellule nelle fabbriche e nei quartieri operai della capitale Berlino. Nell’estate del 1942 si formò una nuova direzione, composta da oppositori scampati agli arresti o usciti dalle prigioni: l’insegnante Fritz Lange, l’impiegato Martin Weise, il giornalista Wilhelm Guddorf e il meccanico di precisione Bernhard Bästlein, proveniente da Amburgo dove aveva partecipato all’insurrezione del 1923. Ma tra l’ottobre e il dicembre del 1942 anche la nuova organizzazione venne brutalmente scompaginata dalle autorità. Nonostante l’isolamento e la barbara efficienza della repressione nazista, nell’inverno 1943-44 si ricostituì attorno ad Anton Saefkow, Bernhard Jacob e allo stesso Bästlein una rete organizzativa capillare in una settantina di fabbriche di Berlino. Saefkow, proveniente dalla gioventù comunista del quartiere di Kreuzberg, era stato incarcerato tra il 1933 e il 1939 per le attività clandestine condotte per il KPD. Tuttavia, Saefkow mantenne le distanze dalla direzione estera del partito e dalla strategia del Komintern. A giudizio di Hermann Weber, storico del KPD, i dirigenti operai comunisti della città avevano assunto «un ruolo sempre più autonomo, tanto che non li si può certo definire diretti dall’estero, o esecutori degli ordini di Mosca»[6]. Una tesi confermata da Hans-Reiner Sandvoss che ricostruisce in maniera minuziosa la resistenza al nazismo in ogni quartiere di Berlino[7].
 |
La memoria della resistenza tedesca in Italia
Il campione composto dalle 1.777 esecuzioni capitali operate tra il 1940 e il 1945 nel carcere di Brandeburgo per motivi politici o militari dimostra la definita collocazione di classe di gran parte delle vittime del nazismo: 1.250 erano infatti operai e lavoratori salariati. Tra questi ci fu Rudolf Seiffert, dirigente comunista nel quartiere berlinese di Wedding e organizzatore per il gruppo S.J.B nella sua fabbrica, la Wemer Werke Siemens, la cui esecuzione avvenne nel gennaio del 1945.
A Seiffert è dedicata una lapide all’interno della Casa dello Studente di Genova dove si trova il Museo permanente della resistenza europea. Un luogo carico di significato: la Casa dello Studente durante la guerra fu la sede del “sotterraneo dei tormenti”, luogo scelto dalla Gestapo per praticare sevizie e torture contro partigiani ed antifascisti. Un gruppo di studenti internazionalisti nel 1974 indicò proprio il nome di Seiffert per ricordare il legame ideale tra quei partigiani europei che scelsero di combattere in nome di una società senza classi e senza frontiere. L’ispirazione venne data da Antonio Bogliani, partigiano combattente savonese, che in un discorso alla Casa dello Studente del 1972 ricordò «il martirio dell’opposizione tedesca al nazismo». Bogliani a sua volta riprendeva le parole scritte da Arrigo Cervetto nella recensione apparsa sul giornale comunista libertario “L’Impulso” il 15 agosto 1954 alla prima edizione italiana delle “Lettere dei condannati a morte della resistenza europea”[8]. Fu una della rarissime prese di posizione pubbliche che nel primo dopoguerra riprendevano in Italia apertamente il filo della memoria della Widerstand.
Già nel 1987 in occasione del convegno organizzato dal Goethe Institut di Roma e dall’Università La Sapienza, Jens Petersen, vicedirettore dell’Istituto storico germanico sino al 1999, lamentava proprio la «netta chiusura e quasi un rigetto del Widerstand in quasi tutta la sinistra italiana antifascista» e sottolineava che «nessuna delle opere fondamentali in questo campo [...] è stata tradotta in italiano». Nel suo “Battaglie e principi per una politica comunista”, Roberto Casella ha affrontato il tema di questa «pagina tenuta nascosta», rilevando come «nonostante i temi resistenziali facciano parte del costume politico e delle ricorrenze celebrative dello Stato, l’opposizione tedesca al nazismo è pressoché sconosciuta. Al contrario viene diffusa l’idea che tutto il popolo tedesco si sia identificato nel nazismo».[9]
Sono considerazioni sostanzialmente valide ancora oggi. Se si eccettuano gli studi sui complotti militari per liquidare Hitler o su alcuni toccanti episodi dell’opposizione cattolica e confessionale, non esiste una sistematica bibliografia sulla resistenza tedesca al nazismo né tantomeno su quella specificamente operaia.
La «pagina nascosta» del Widerstand e quella ancor più dimenticata dell’opposizione proletaria al nazismo rimangono però come eccezionale espressione di internazionalismo e di solidarietà di classe in uno dei momenti più bui della storia dell’umanità, dove il razzismo ed il genocidio vennero elevati, con l’efficienza propria della produzione capitalistica, a pratica statale e industriale.
Speciale 25 Aprile 2020: Introduzione Spagna Clandestina
[1] Intervento di Giuseppe Bonfratello al convegno “La società tedesca tra nazionalsocialismo e Widerstand”, 29-30 novembre 2018, Polo del ‘900, Torino.
Julius Leber (1891-1945). Deputato dell’SPD durante la repubblica di Weimar, con l’avvento del nazismo fu arrestato e rinchiuso nel campo di concentramento di Sachsenhausen fino al 1937. Coinvolto nel fallito attentato a Hitler del luglio 1944, venne giustiziato nel gennaio 1945.
[3] Willy Brandt, “Memorie”, Garzanti, 1991.
[4] Peter Hoffman, “Tedeschi contro il nazismo”, Il Mulino, 1991.
[5] Jacques Nobecourt (1923-2011) fu corrispondente di “Le Monde” in Italia tra il 1965e il 1974.
[6] Hermann Weber, “Die Wandlung des deutschen Kommunismus”, Europäische Verlagsanstalt, 1969,
[7] Hans-Reiner Sandvoss, “Die `andere’ Reichshauptstadt”, Lukas Verlag, 2007.
[8] Luigi Barco, Piero Ferrazza, “La Casa dello studente di Genova. Una pagina della Resistenza”, Edizioni Pantarei, 2012 |
[9] Roberto Casella, “Battaglie e principi per una politica comunista”, Edizioni Lotta Comunista, 2007.